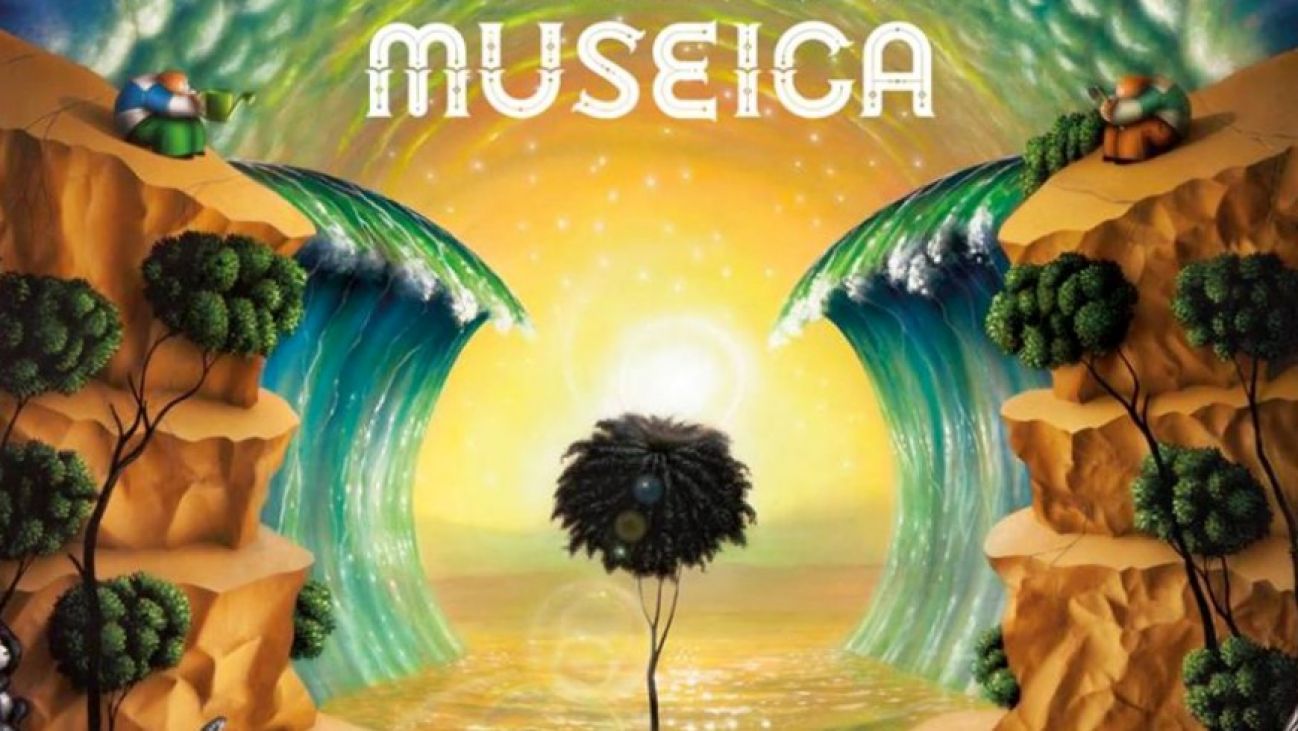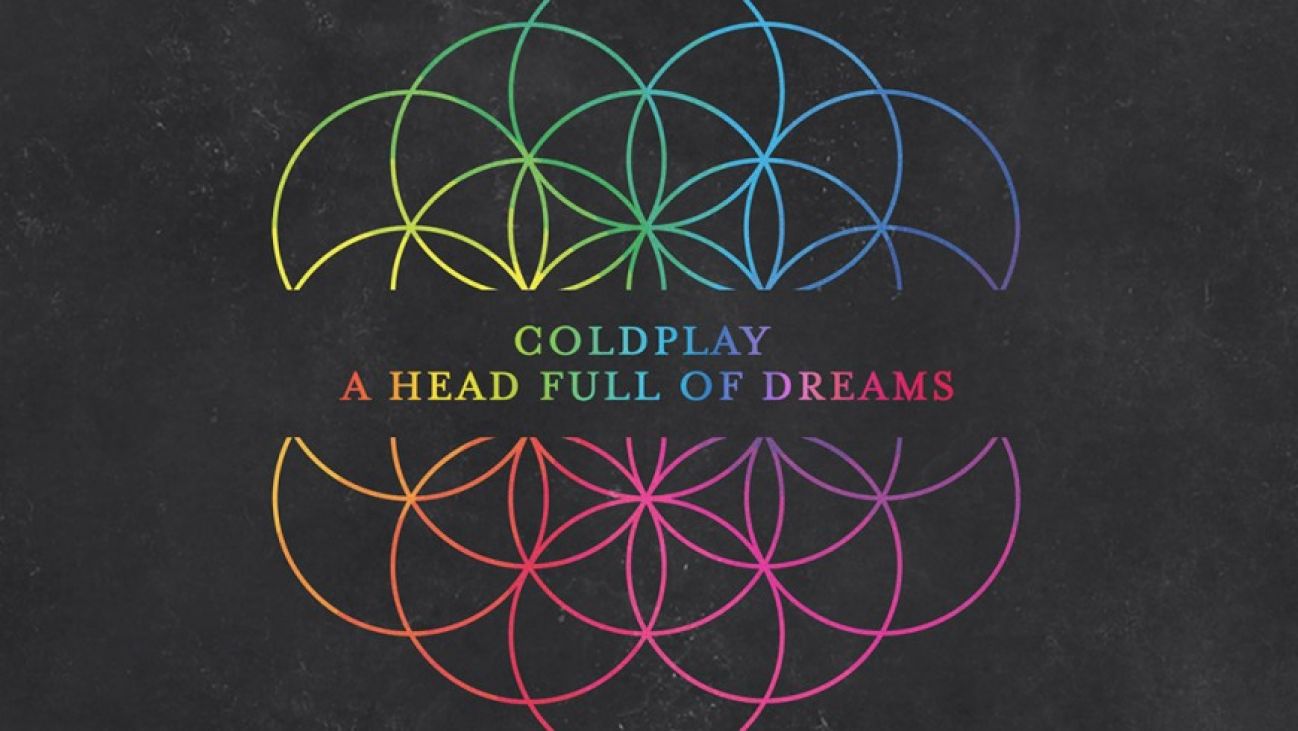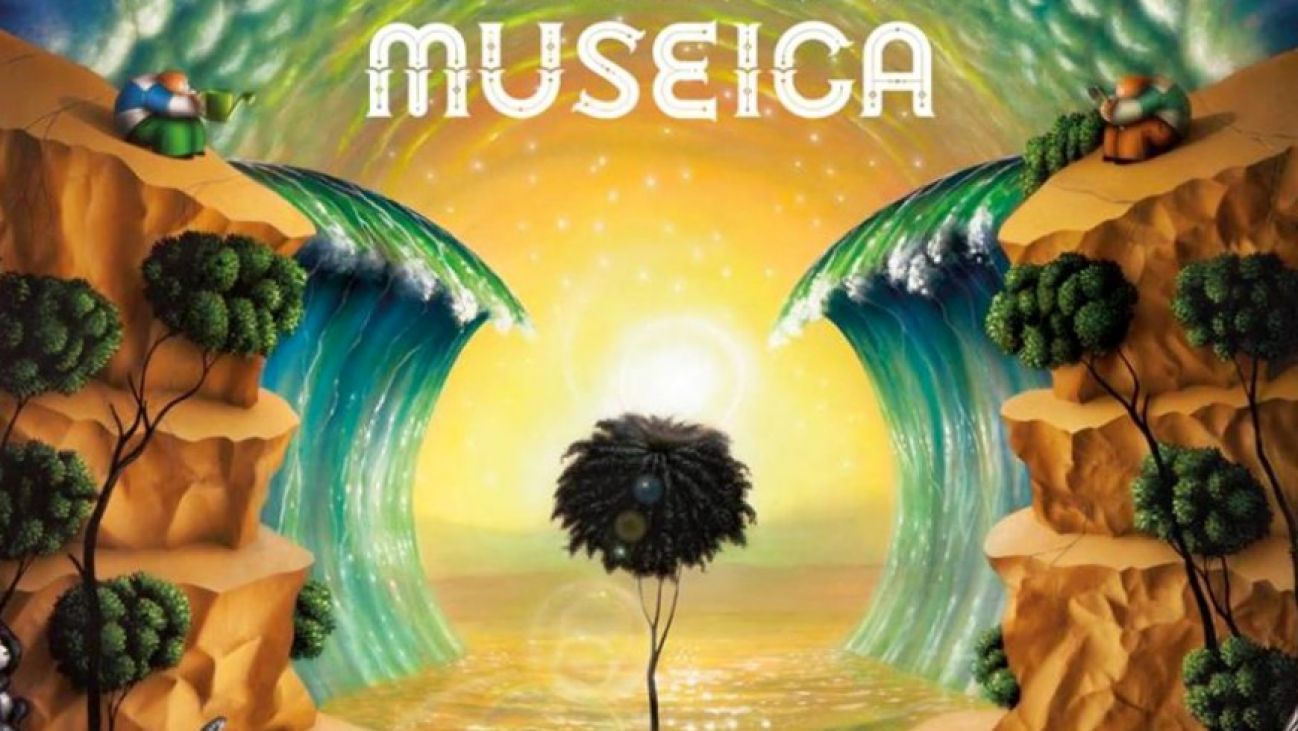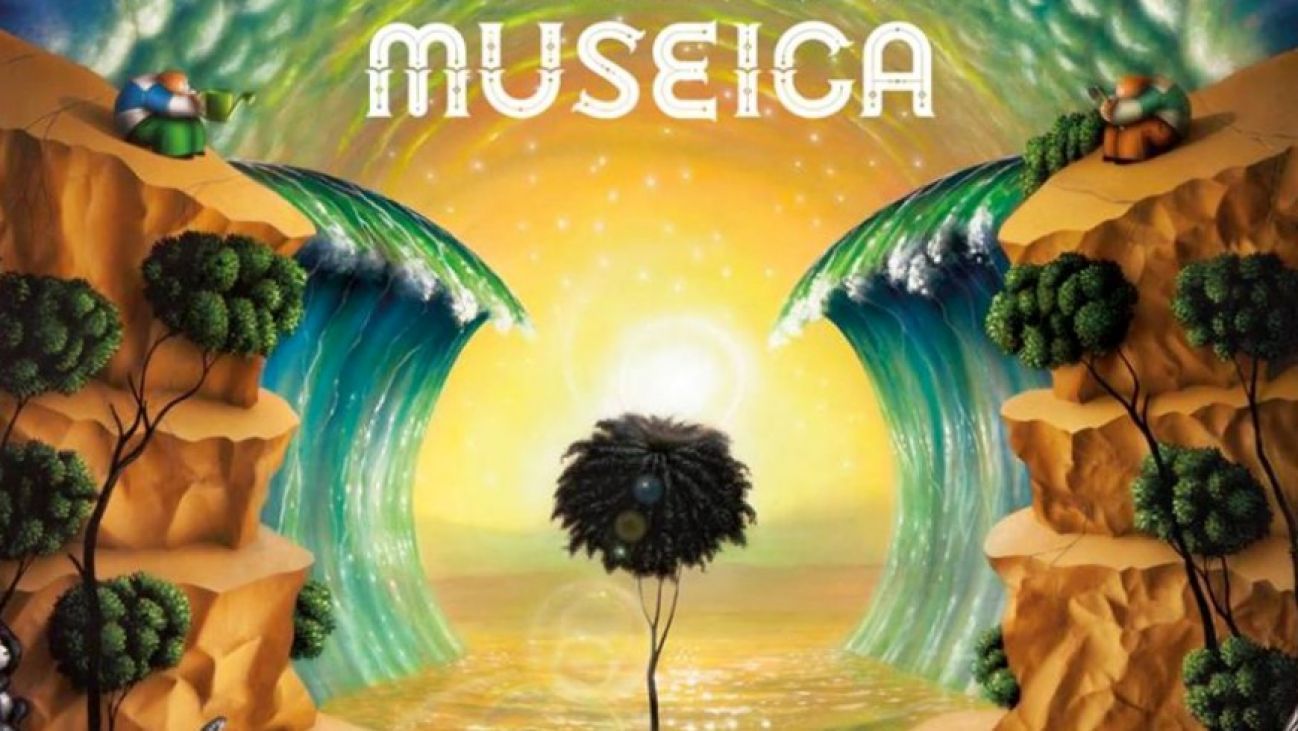Birds without names è il film che non vedrete mai. Si tratta dell’ultima opera di Kazuya Shiraishi, regista giapponese classe 1974 e allievo del grande Kōji Wakamatsu, di cui vi invitiamo leggere la filmografia (e soprattutto i riconoscimenti).
Se già le pellicole del suo maestro circolano sul mercato europeo con la stessa frequenza degli omicidi nei cinepanettoni, per recuperarne una di Shiraishi dovreste scandagliare l’internet consapevoli di dovervi affidare ai sottotitoli.
E dato che siete pieni di cose da vedere e difficilmente potrà venirvi voglia di cinema nipponico sconosciuto e grottesco, eccoci a raccontarvi l’ultimo film della Festa del Cinema di Roma come se al Teatro Studio ci fosse stati anche voi.
Periferia di Osaka. Towako e Jinji, di quindici anni più grande di lei, vivono in un appartamento piccolo e disordinatissimo. Lui è brutto, goffo, malvestito e sporco, lavora come operaio e guadagna il minimo per sopravvivere e per mantenere la sua ragazza. Lei non fa assolutamente nulla, tranne che insultarlo ad ogni occasione, anche quando lui torna a casa col dessert delle grandi occasioni (una torta ripiena confezionata, comprata al supermercato).
Forse è per questo che la donna comincia a tradire il compagno con l’affascinante Mizushima, uomo d’affari con moglie e figli. La relazione le fa tornare in mente Kurosaki, il grande amore del passato, e qui cominciano i flashback, girati in spazi più ariosi e con una fotografia più luminosa rispetto alle scene del presente. Il crimine è l’universo di riferimento di Shiraishi, che nei film precedenti non disdegna sequenze a base di sesso e violenza.
E infatti, la storia prende una piega morbosa. Jinji comincia a seguire Towako e Mizushima, facendosi anche notare, ma questo non basta a interrompere il loro rapporto. Una presenza costante che comincia ad inquietare la coppia di amanti: lui è convinto che l’uomo gli abbia rubato dei documenti importanti, la cui perdita manderebbe in rovina la sua attività; lei comincia a temere per l’incolumità di entrambi e comincia persino a pensare che Jinji possa essere responsabile dell’improvvisa scomparsa di Mizushima, quindici anni prima.
Da qui in poi comincerebbero gli spoiler e sarebbe un peccato, perché Birds without names punta molto sul “niente è come sembra” e, magari, qualcuno di voi avrà l’ardire di recuperarlo, prima o poi. Dal punto di vista tecnico Shiraishi sa il fatto suo: abbiamo apprezzato qualche invenzione visiva, la fotografia crepuscolare contrapposta a quella dei ricordi di Towako e la scelta di ambientare la vicenda nell’anonimato del contesto suburbano. Gli attori, poi, sono perfettamente calati nel ruolo mai facile di personaggi disfunzionali. Ma di cosa parla, davvero, il film?
Siamo di fronte a un dramma sentimentale che sconfina nel thriller psicologico. Come una tragedia greca, la vicenda è il pretesto per scoprire le origini di un trauma e per conoscere la verità su fatti lontani. Il regista e autore tesse una trama che lega l’evanescente soggettività dei ricordi al tema dell’abbandono, attraverso il punto di vista di una protagonista ferita dalla fine di un amore.
E lo fa bene: tutto ci sembra plausibile, svelato coi tempi giusti, seppur con una linearità priva di particolari sussulti. Ma forse questo è l’aspetto più personale della pellicola, ovvero l’intenzione di sottolineare l’ineluttabilità degli eventi, dato che tutte le scene, anche quelle rivelatorie del finale, contano su un uso della musica accomodante che contrasta con la violenza delle immagini, come se l’esito di quell’evento sia l’unico possibile: la rassicurazione che non poteva andare altrimenti.
Il problema sta nell’epilogo. Una volta fatta luce sul passato dei protagonisti, il film propone una soluzione così tragicamente plateale da superare i binari del plausibile. Non siamo i soli ad aver faticato invano per tentare di inquadrare un’opera che tutto sommato, fino in quel momento, aveva detto qualcosa di sensato sul dolore dell’amore e sulla solitudine. Ed è sempre nel finale che Shiraishi sceglie di esplicitare il significato contenuto nel titolo con una chiosa e una messa in scena davvero dimenticabili.
Foto: Getty Images
Paolo Di Marcelli