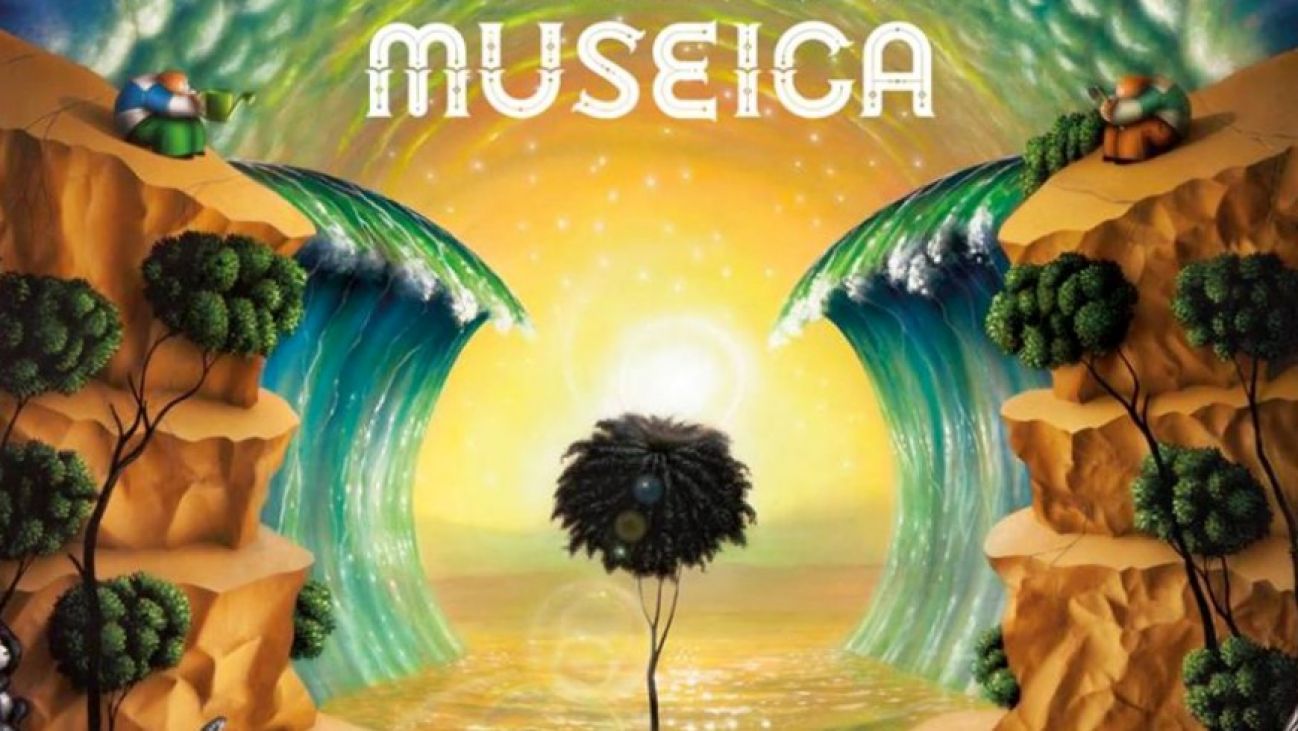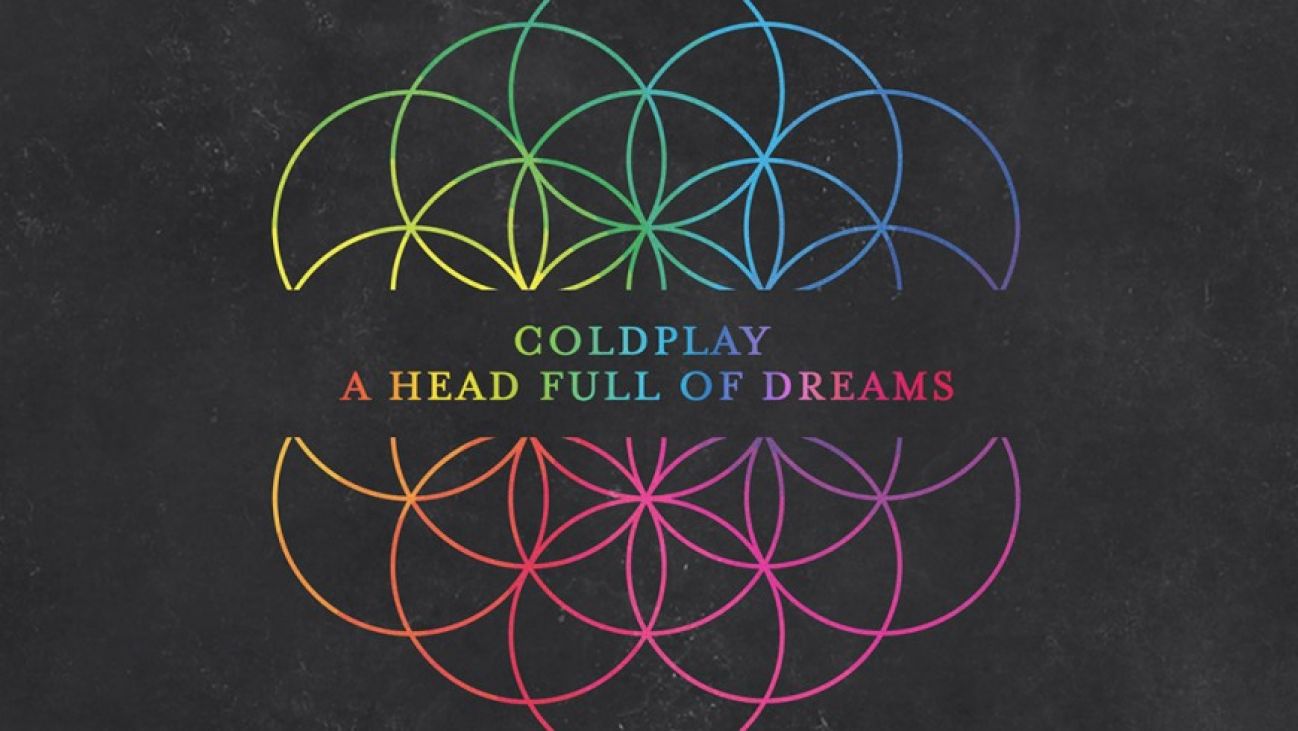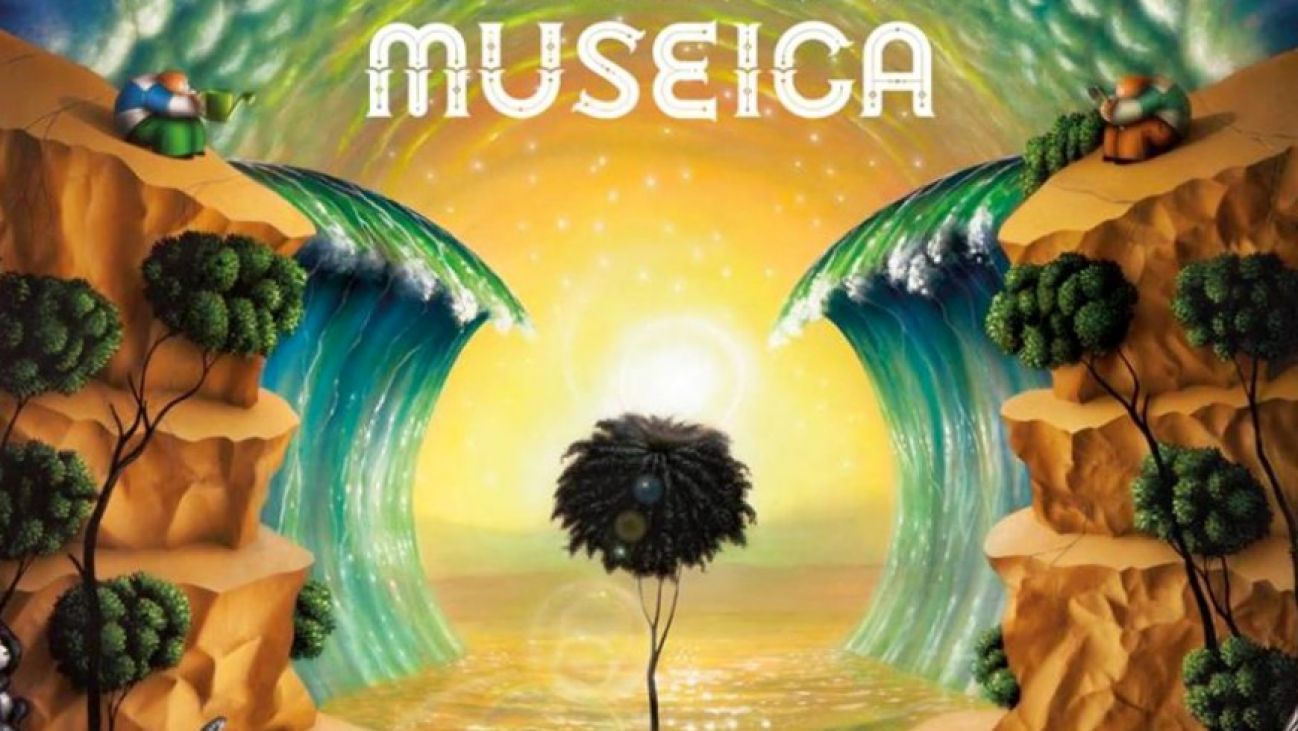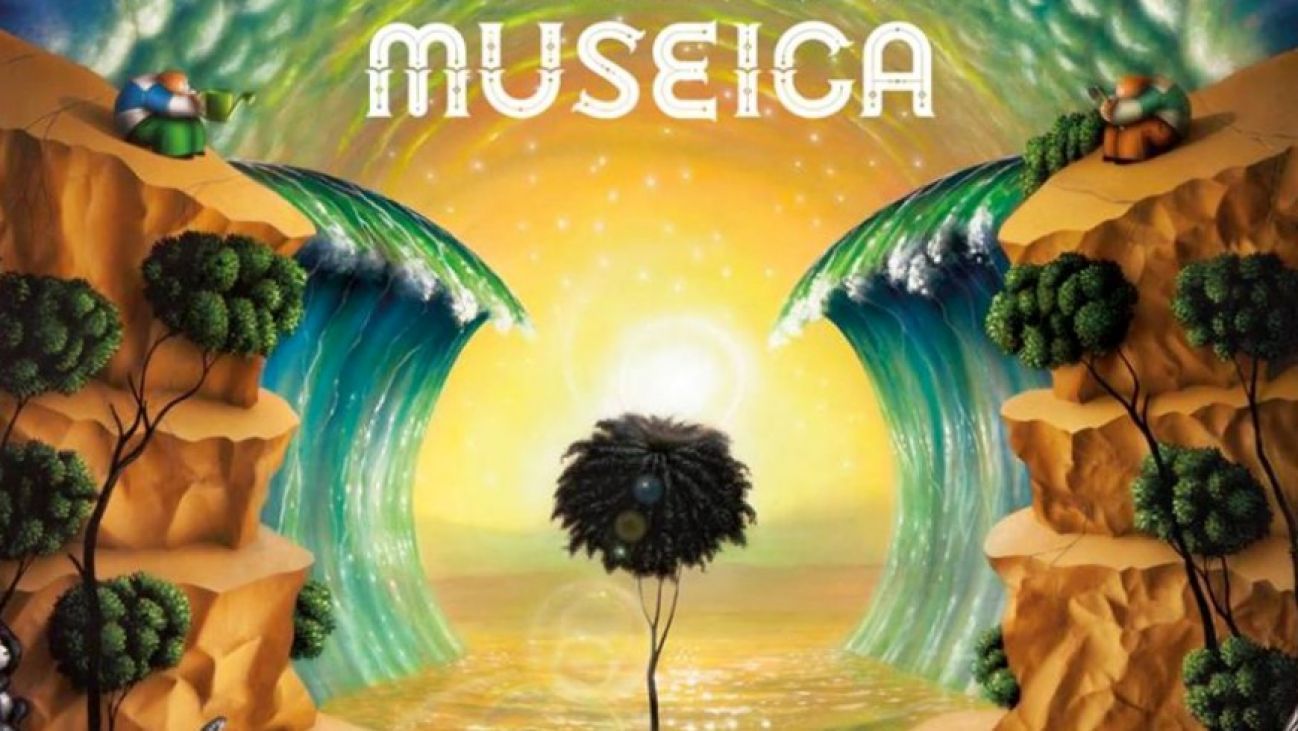Il palcoscenico, allestito semplicemente con un cerchio di luce e un leggio, è quasi una gabbia entro cui Luca Trezza si muove incessantemente, come una belva ferita, è uno stretto spazio che Trezza riempie con il proprio movimento. Ora il gesto accompagna la parola, ora la musica; oppure ci va contro, nega il significato del discorso, pronunciato in un miscuglio di dialetto (napoletano, romano) e lingue straniere (inglese, francese) e contrappuntato da ammirevoli esercizi vocali. Lo spunto drammaturgico è quello di un uomo -forse sposato con un'incostante Nadia, ma non potrei giurarvelo- che finalmente ottiene un appuntamento da una ragazza misteriosa (tal “X”) conosciuta in chat. Mentre vi si sta recando, incominciano a riaffiorare i ricordi della propria infanzia: la nonna sul punto di morte, “il latte di mammà, la chancon di papà, i gatti e le falene”. Ricordi spesso dolorosi, di quella incomunicabilità che il mondo virtuale finge di abbattere. La lettura delle tipiche conversazioni da chat o delle presentazioni dei profili conquista infatti il pubblico, che ride, forse anche un po' riconoscendosi. X non si presenta, ma questo tanto ricordare è servito a qualcosa: a mettere un punto, anzi un punto e a capo.
Luca, questo non è il tuo primo spettacolo che accoglie una riflessione sui nuovi modi di comunicazione... come mai questo interesse così marcato?
Non c'è nessuna intenzione di critica verso la comunicazione telematica, intermediata, che io chiamo “l'oppio della nuova generazione”; so di appartenere io stesso a questa dimensione. Piuttosto, secondo me, esiste un parallelismo tra le chat e il teatro: in entrambi casi si dice al buio qualcosa di sé. Nella situazione creata da una chat ci vedo qualcosa di beckettiano. Mi interessano poi moltissimo i balbetti del T9, gli errori che si compiono scrivendo al computer o al telefono, le emoticon; credo che stiamo assistendo alla nascita di una nuova tipologia di scrittura, che ha tutto il diritto di entrare in un testo teatrale.
Parliamo un attimo della tua interpretazione: il gesto e la vocalità sono i tuoi mezzi preferiti per comunicare con il pubblico. Forti sono anche gli elementi della tradizione partenopea. Qual'è la tua formazione?
Per quanto riguarda la tradizione, ti dico subito che è un elemento “non voluto”, nel senso che fa parte della mia storia e delle mie radici, e che dunque esploro al suo interno proprio perché vi sono spinto “naturalmente”. Io mi sono diplomato nel 2007 all'Accademia Silvio D'Amico, che è stata una bellissima esperienza; ma l'accademia deve dare degli input, poi bisogna farsi da sé la propria accademia quotidianamente. Presto ho sentito quindi il bisogno di fondare una compagnia che fosse orientata verso questa ricerca costante più che all'allestimento di spettacoli di successo, per esplorare assieme degli allenamenti che fino ad allora avevo svolto per conto mio.
Alla Casa delle Cultura hai tenuto più volte training, e anzi a partire da lunedì 18 ci saranno delle prove aperte al pubblico con i ragazzi dell'anno scorso. Come si svolgono questi allenamenti?
È un training molto esigente. Si allena fisicamente il corpo e poi la capacità d'improvvisazione sulla musica, che ritengo importantissima: a volte è la musica stessa che ti dà la “storia” su cui costruire un'azione drammatica. Il training va visto come un continuo andare in scena tra attori; è molto faticoso ma alla fine ti scatta un click dentro, un'apertura alla creatività che ti resta per il futuro.