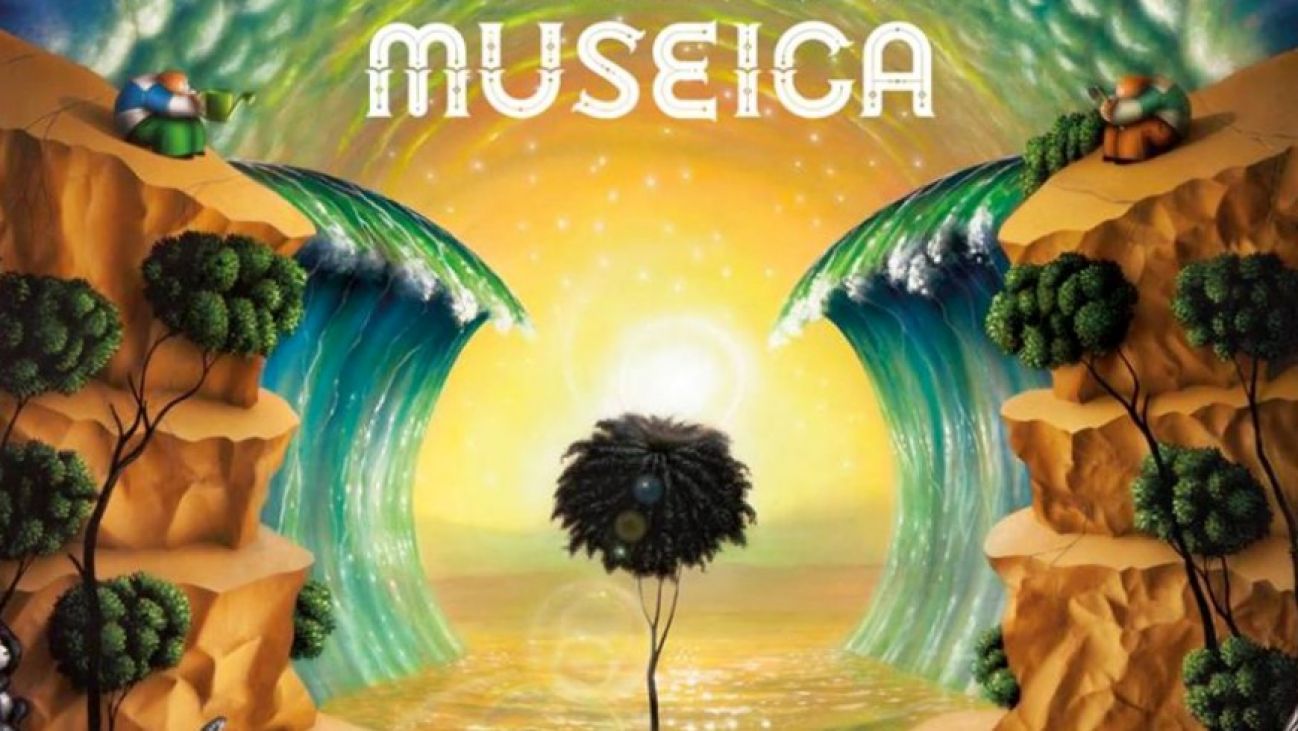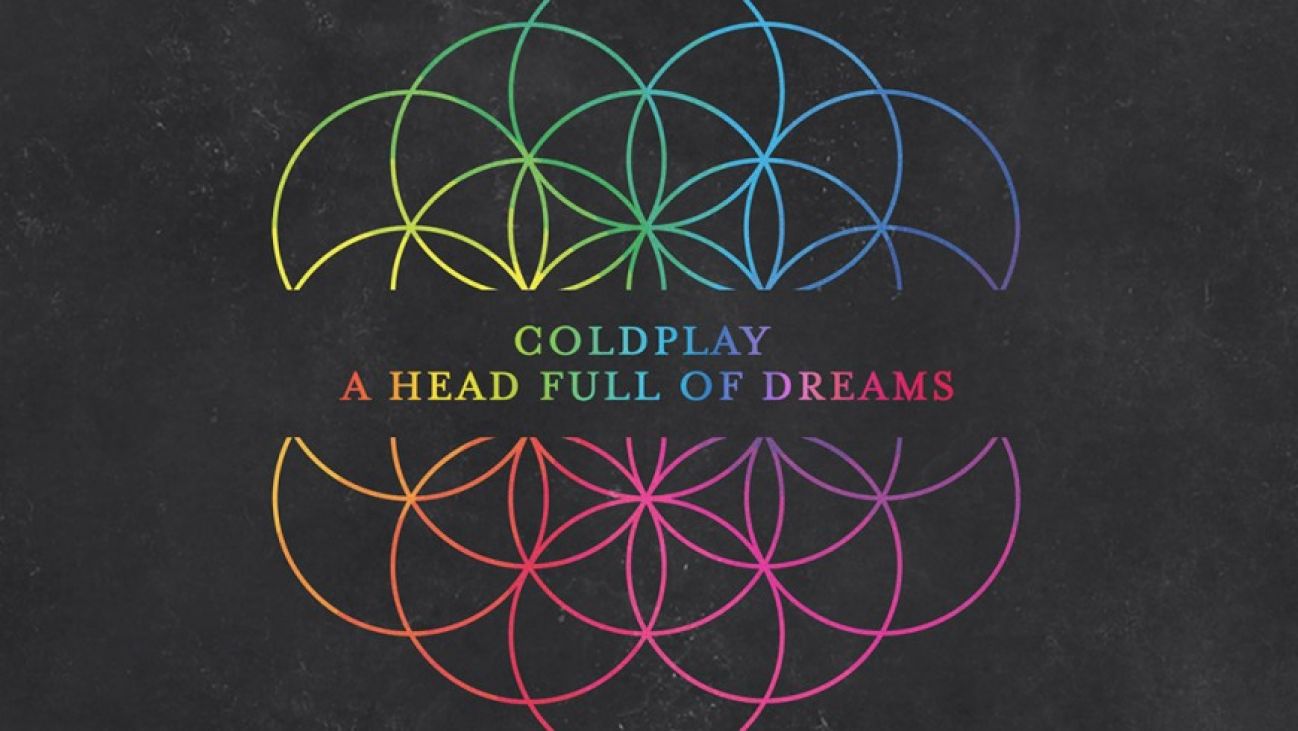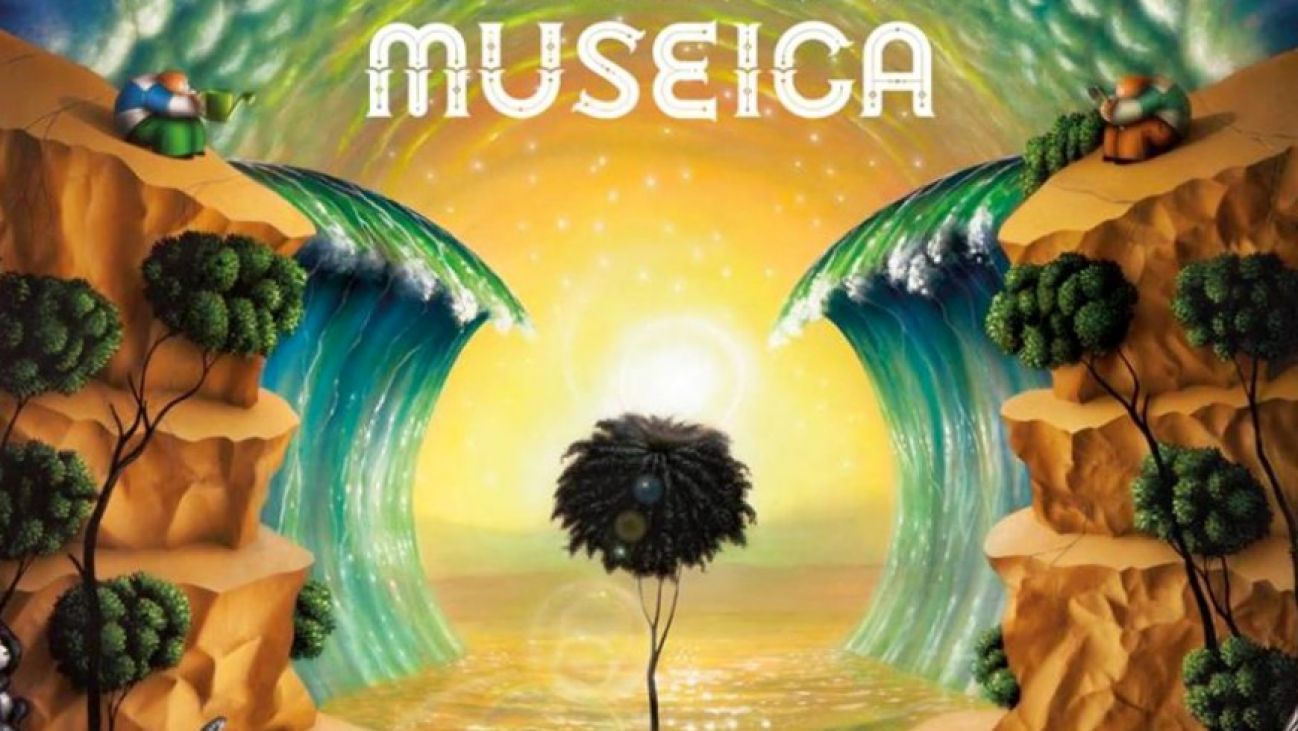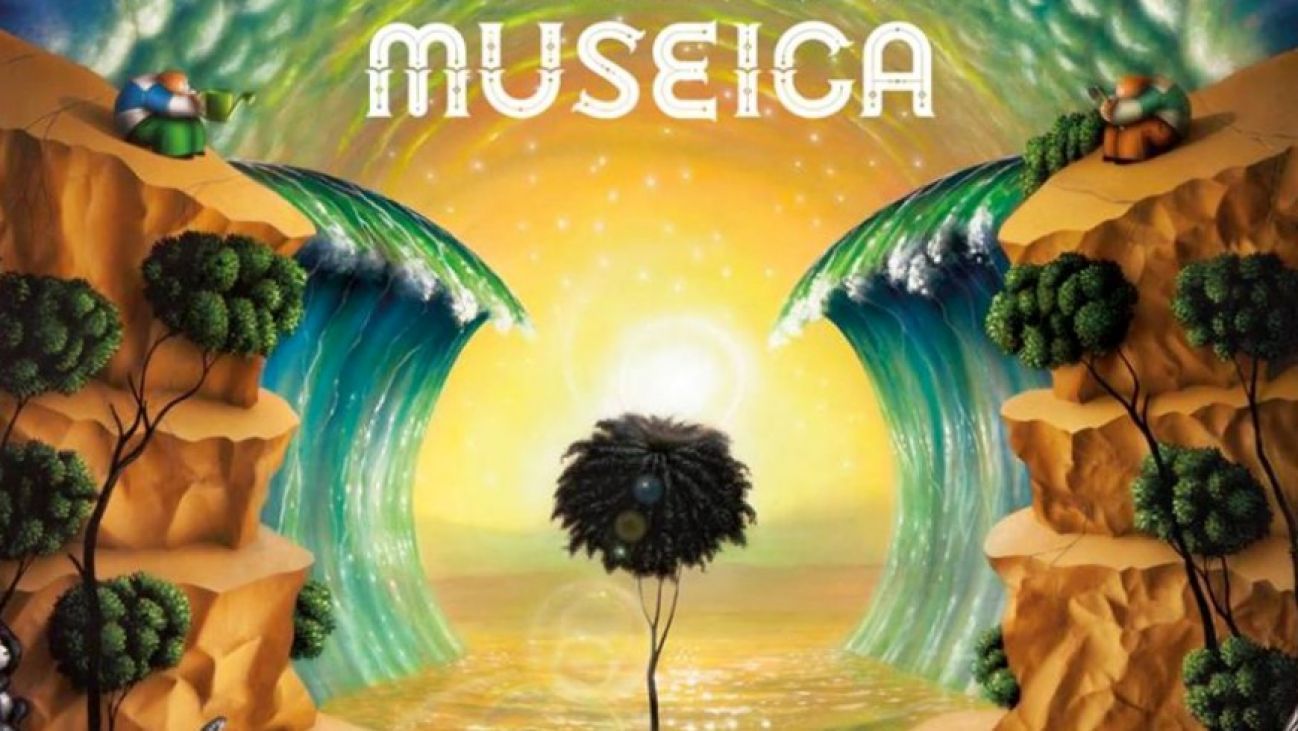Oggi quella tradizione viene rinverdita con la rassegna Jazz Evidence, già in corso da diversi mesi, che ha visto salire sul palco del Monk Club alcuni tra i migliori nomi legati, chi più chi meno, a doppio filo con il jazz di una volta e quello a venire. Un’operazione meritoria per un locale che ha saputo differenziare la propria offerta artistica, richiamando per questa rassegna un tipo di pubblico che difficilmente avrebbe imboccato via Giuseppe Mirri per eventi di altro genere.
Questa sera la storia bussa di nuovo e prepotentemente alla porta. Di lui, Fela Anikulapo Kuti ebbe a dire “without Tony Allen, there wouldn't be any Afrobeat”. A rimarcare, come se ce ne fosse bisogno, l’importanza del motore pulsante del genere nato nei primi anni ’70 nel cuore dell’Africa. Nigeriano, classe 1940, un Allen non ancora pago di girare il mondo viene a trovarci insieme ai gloriosi Jazz Messengers per aggiungere un altro tassello chiave a questo viaggio nel jazz. E lo fa mettendo pelli e tamburi al servizio di un altro gigante della batteria e fondatore, assieme ad Horace Silver, proprio dei Jazz Messengers: Art Blakey, assoluto innovatore dello strumento.
La sala è gremita, tra sedie, poltrone e gente in piedi. I quattro si dispongono a ferro di cavallo, con la batteria opportunamente al centro. La scaletta è sostanzialmente la stessa nei diversi live del tour (qui un’esibizione deliziosa) e dunque si inizia con ‘Invitation’ e il discreto tocco di Mathias Allamane sul contrabbasso. Tony Allen detta il tempo con il suo drumming inventivo mentre il sax tenore di Jowee Omicil disegna la trama che informa e dà corpo alla melodia. A dir la verità, durante i primi minuti si percepisce una certa tensione nell’aria, forse complice il rispettoso silenzio che scende tra la gente, disturbato solo da un po’ di brusio sul fondo della sala. È un misto di aspettativa e timore, come se qualcuno possa sbagliare un tocco o una nota o che il dialogo tra i quattro musicisti possa non andare a buon fine. Non so dire bene perché, forse si denota ancora una certa freddezza all’inizio dell’esibizione. La sensazione man mano si dissipa, però, in favore di un flusso musicale che si fa più fluido e naturale man mano che la serata avanza. Ciò che diventa chiaro dopo pochi minuti e che tutti e quattro i musicisti hanno una spiccata personalità; ognuno nel suo ruolo, ma non esistono gregari. Allen ha la capacità di saper sparire dalla scena, caratteristica che, lungi dal fare rima con inconsistenza, mette in luce l’umiltà di questo personaggio. Durante i brani, dimentichi quasi che sia lì a modellare la pasta ritmica dell’insieme: il brano semplicemente va, non c’è bisogno di enfatizzarlo con colpi di scena, puoi concentrarti su altri aspetti, la batteria è là e ci puoi contare a orecchie chiuse. Il nigeriano riemerge invece al momento dell’assolo: non sono forse i momenti suoi più riusciti della serata (mentre è imbattibile nel mezzo del pezzo), ma sono spunti per apprezzare il drumming inusuale di questo artista, che sembra adottare lo stile imprevedibile di un Thelonious Monk alla batteria. I brani hanno una struttura piuttosto standard: si parte col tema, ciascun musicista ha la sua vetrina d’assolo col suo strumento, ritorno del tema e chiusura finale. A maggior ragione questo aiuta a sbirciare attraverso lo spioncino e studiare i movimenti, le manie e gli assi nella manica di ognuno dei quattro. Allamane al contrabbasso non disdegna le luci della ribalta, negli assoli e non solo: ogni brano comincia con le sue note e, benché lo strumento lo ponga naturalmente nelle file dell’accompagnatore e non del solista, fa sentire la sua presenza e la formazione ridotta mette in luce le sue doti. Una buona tecnica al servizio - e fa la differenza - di un ottimo gusto. In ‘Are You Real’ Omicil passa al sax soprano, che non abbandonerà più fino al termine dell’esibizione, eccetto in un caso. E questo lo aiuterà a sfoggiare il suo istinto da istrione: salta, disegna piroette col sax, fa il fenicottero come Jan Anderson. È un po’ il jolly della formazione, libero di spaziare in lungo e largo nello scacchiere, con una certa anarchica libertà. Croce e delizia, si direbbe, dà quel tocco d’imprevedibilità a ogni composizione, ma con lui sembra sempre di camminare lungo un filo sospeso sull’abisso: alcune intuizioni colpiscono nel segno, altre si risolvono a metà, lasciando qualche perplessità. Il campione della squadra: capace di risolvere da solo una partita ma, quando va male, può girare un po’ a vuoto. Di brano in brano diventa sempre più chiaro invece come il timoniere del combo, la croce del sud che indica il cammino ai viandanti è Jean-Phi Dary. È lui che detta la regole del gioco, che tiene le redini, grazie a un piano mai invadente ma determinante e al meraviglioso suono di quel Fender Rhodes. I suoi opportuni cambi d’accordo cambiano il colore delle composizioni e le dirigono lungo la melodia; ciò diventa ancor più chiaro nei passaggi finali, in cui Dary dà il segnale e gli altri seguono, non sempre felicemente. Se c’è una cosa che va migliorata, in base al mio umile giudizio, sono i finali: ogni volta sembra che non ci riesca a mettere d’accordo sul dare una sensazione di crescendo, di diminuendo o di cosa, con un risultato che a volte sa un po’ di abborracciato.
In ogni caso, la serata è piacevole e riuscita e ha messo in luce grandi individualità: c’è forse solo qualcosa ancora da limare nell’interplay tra i musicisti. L’esibizione si conclude con un’encore inaspettata: un brano dal ritmo calypso, quasi un gradito divertissement prima di chiudere quest’altra pagina di Jazz Evidence. Ed è evidente ancora una volta come l’affetto per l’Afrobeat qui nella capitale (Orlando Julius è stato al Quirinetta non molto tempo fa) non tema crisi.
Eugenio Zazzara