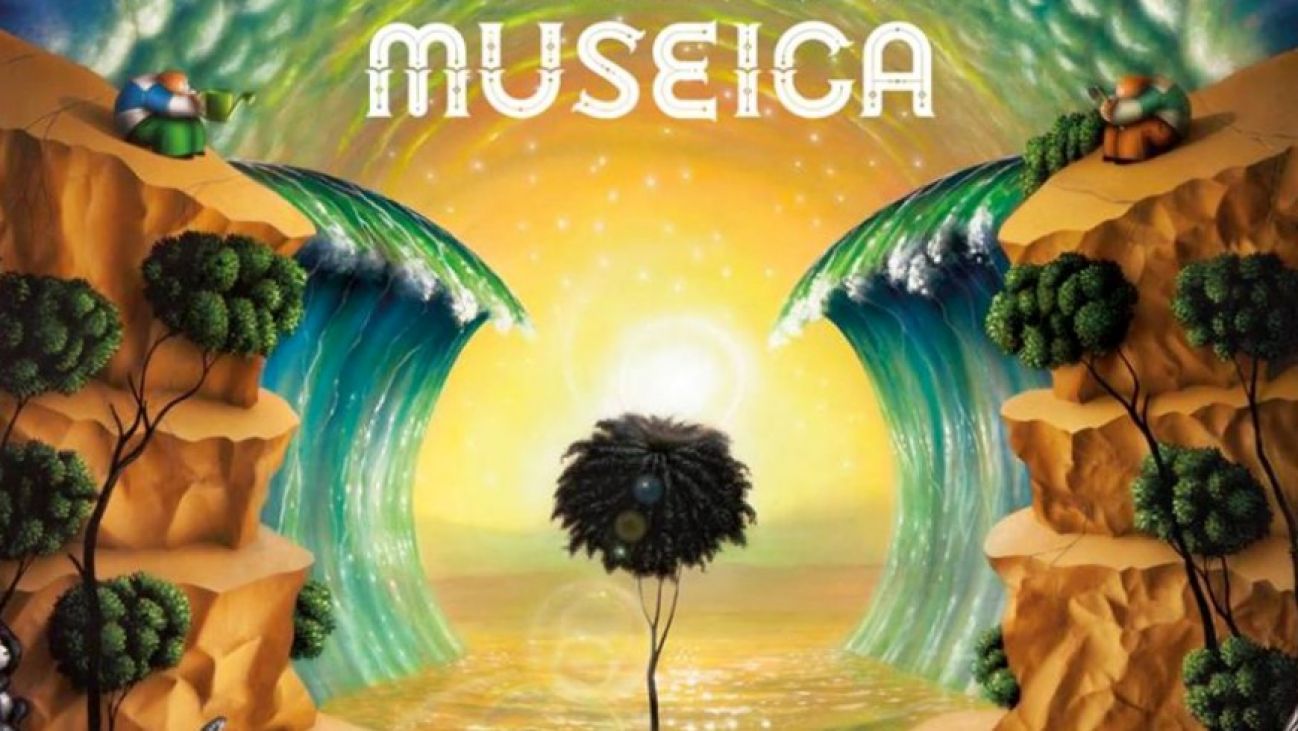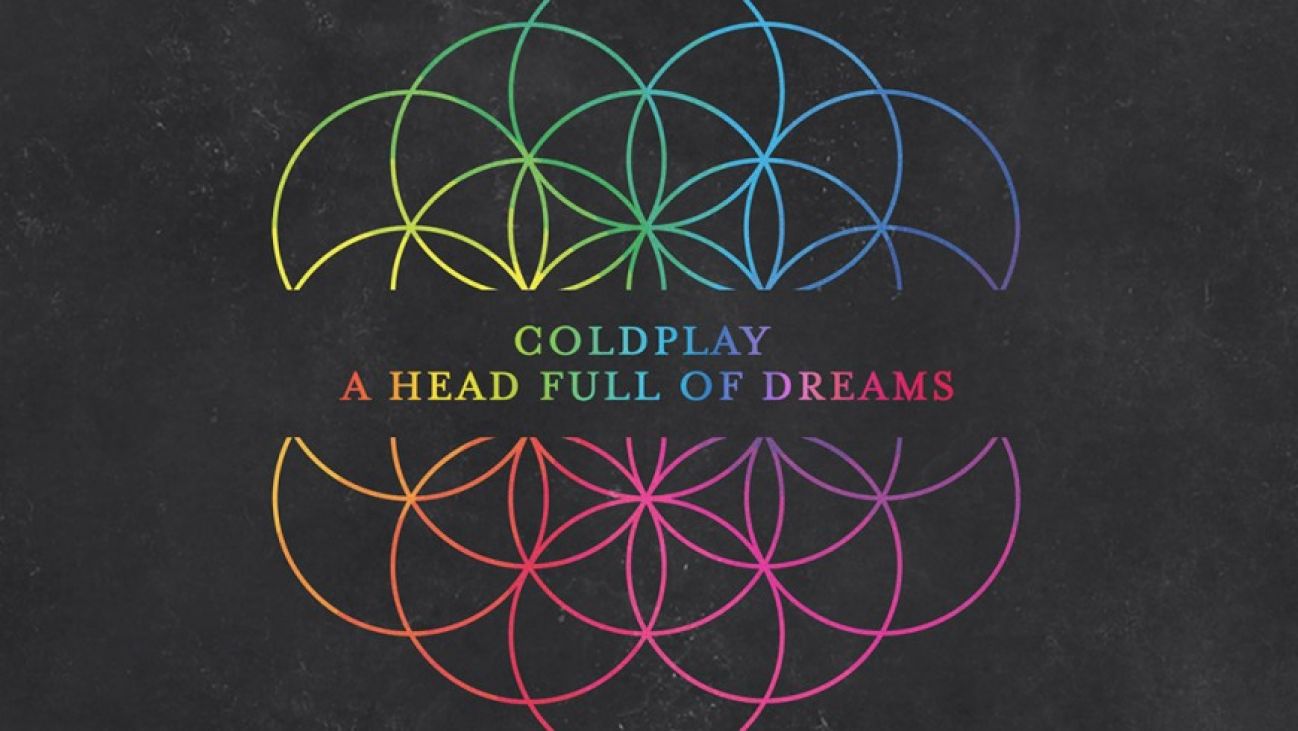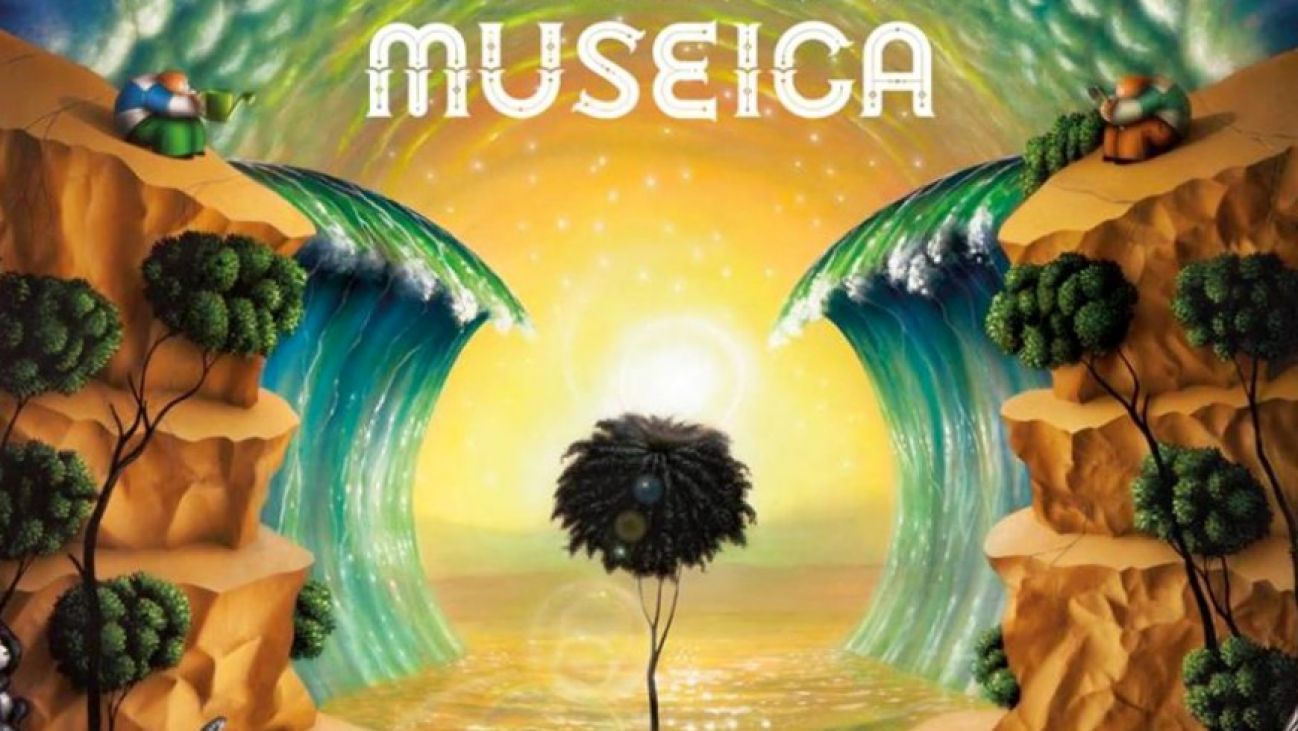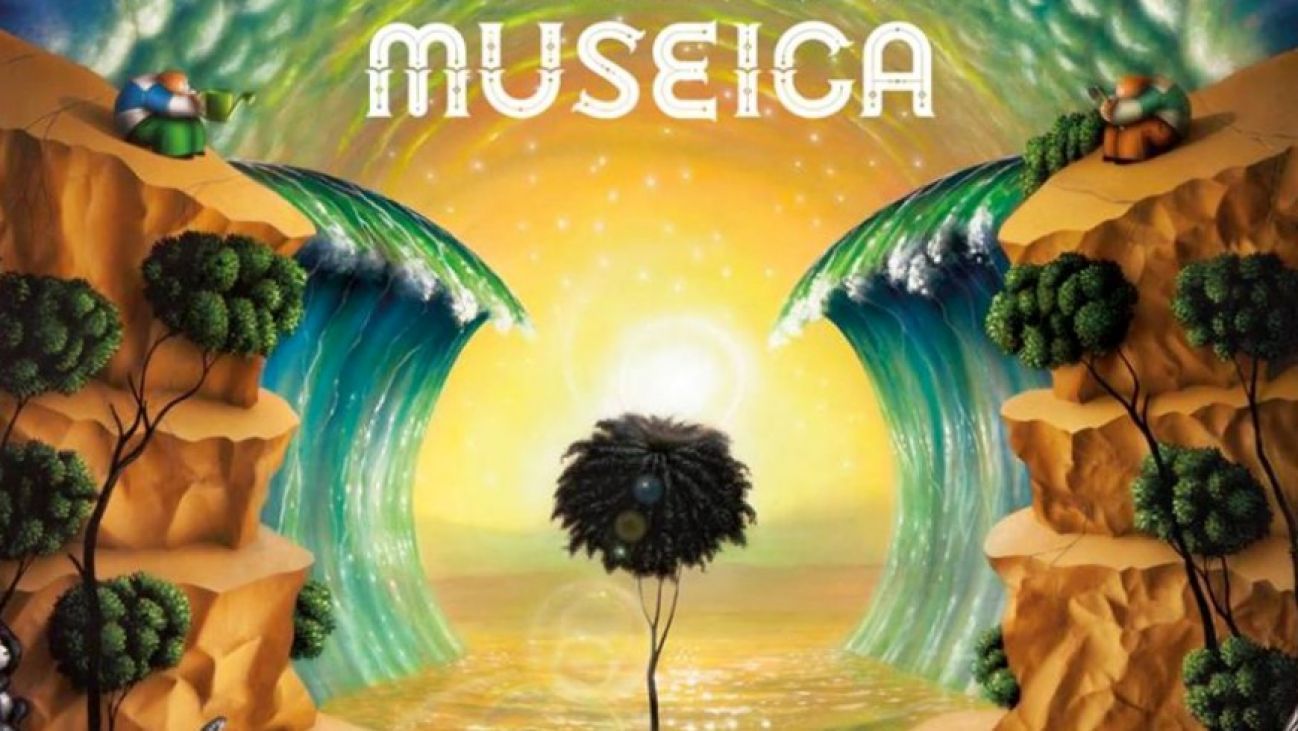Sono un fan sfegatato del film di Sean Penn e delle canzoni scritte e interpretate da Eddie Vedder. Lo sono così come si può esserlo della produzione dei Nirvana o di qualsiasi altro prodotto generazionale che si può ascoltare o vedere fino allo sfinimento in una parte precisa della propria vita (adolescenza e/o vent’anni) per poi crescere e dimenticarsene sapendo che ci si può sempre tornare, per mille motivi, quando si ha la voglia di coltivare un po’ di sana nostalgia. Per questo, sulle prime, ho accolto con entusiasmo la notizia di uno show che gira l’Italia ispirandosi al fortunatissimo lungometraggio del 2007 nonché alla storia vera di Christopher McCandless, il ragazzo che decise di lasciarsi alle spalle famiglia, amici e civiltà per addentrarsi in completa solitudine nel cuore selvaggio dell’America.
Ma ero confuso. Un concerto-omaggio: che significa? Fino al giorno prima mi sono accontentato di quel poco che avevo letto di sfuggita, ovvero che non ci sarebbe stata solo la musica, ma anche racconti e testimonianze di vita in linea con lo spirito del film. Alla fine, capii che, oltre a tutto questo, le canzoni di Eddie Vedder sarebbero state eseguite fedelmente. Brividi: come si può pensare di fare ed essere la cover band di un progetto simile, di un disco così atipico e intimamente cucito sulla voce e sul carisma del leader dei Pearl Jam, senza suonare sconfitti in partenza?

Ad aprire l’Into the Wild Night è Carlomaria, classe 1993, che a vent’anni mollò tutto per girarsi l’Australia e che decise, poi, di raggiungere l’Alaska per raggiungere il Magic Bus in cui pernottò McCandless. Racconta la sua avventura, ci fa ascoltare i suoi pezzi cantando e suonando (molto bene) la chitarra acustica mentre sullo schermo alle sue spalle scorre un montaggio di riprese che documentano la sua esperienza, alternate alle sequenze del film.
Nonostante manchi un vero e proprio elemento di originalità, qualcosa che aggiunga a questo seguire-le-orme un tratto distintivo che presenti quell’anno “vissuto pericolosamente” come davvero inedito, Carlomaria si merita il palco. Innanzitutto per le ragioni che l’hanno spinto a fuggire, ovvero il momento di sconforto in cui decise di farla finita con la musica vendendo gli strumenti fino all’innamoramento per John Butler, cantautore appunto australiano, cosicché volle incontrarlo (ci riuscì dopo due settimane dall’arrivo). Poi perché il ritorno coincise con un rinnovato spirito creativo che gli permise di muovere i primi passi nell’indie-rock. Questo vuol dire, e ben venga, espandere un universo, ovvero inserirsi in un immaginario consolidato per piegarlo alla propria storia personale. I problemi incominciano con lo spettacolo vero e proprio.

Davide Genco, prima da solo, voce e ukulele, poi accompagnato dall’ottimo Marco Settanni alla chitarra, rifanno le canzoni della mitica colonna sonora di Vedder che tutti conosciamo e allora non capiamo il senso dell’operazione. Si tratta di una cover band a tutti gli effetti (!), col vocalist che incoraggia il pubblico a cantare e a battere le mani in quella che dovrebbe essere una festa collettiva per omaggiare una storia vera, un film e delle canzoni. Una roba da localino o da festa di piazza che abbia come tema qualcosa in comune. Stentiamo a credere che uno show del genere, di derivazione dichiaratamente fandom, possa calcare uno dei palchi più importanti dell’estate romana, quello di Villa Ada – Roma incontra il mondo. È vero, come promesso, che vengono proposte anche altre canzoni, ad esempio Blackbird dei Beatles per via delle sue implicazioni politiche, ma anche qui la questione è la stessa perché ascoltiamo un’esecuzione priva di una personale interpretazione. Tra un pezzo e l’altro Genco parla del film, di Eddie Vedder e di aneddoti vari ma noi riflettiamo sulla tragicità, espressa soprattutto dalla pellicola, cui non si fa cenno. Ricordiamo che l’opera di Penn, nonostante sembri presentare McCandless apparentemente come un eroe, è in realtà un monito a tutti coloro che cercano l’isolamento come soluzione definitiva e soprattutto si pone come un drammatico incoraggiamento a tessere la propria rete di rapporti umani.
Non crediamo, come Giorgio Montanini, che la rivoluzione sia continuamente rimandata per colpa delle cover band; tuttavia ce ne andiamo prima che il resto del gruppo faccia il suo ingresso non perché crediamo che le opere d’arte siano intoccabili – ognuno ha il diritto di riscrivere, ricolorare e ripensare un’opera d’arte a patto che il risultato aggiunga un punto di vista inedito e, appunto, artistico, all’originale – ma semplicemente perché il lavoro canonico di una cover band (strumentalmente validissima, come spesso accade, ma con una voce assolutamente nella media) non si addice all’immenso capolavoro di Eddie Vedder: il rischio di fargli più male che bene, invece di celebrarlo ampliandone l’orizzonte, ci sembra davvero troppo elevato.
Paolo Di Marcelli